Il
mondo offeso di Francesco Lanza
di
Antonio Di Grado
TOTEM
E TABÙ DI SICILIA

(Campagna valguarnerese, foto
di Melo Minnella)
Un
isolano vagabondo, «persuaso (...) della vanità della vita e della stoltezza
degli uomini», si imbatté una volta in una macroscopica e inquietante figura
femminile. Leggiamo il testo, il resoconto di quel singolare incontro:
Ma fattosi più da
vicino, trovò che era una forma smisurata di donna seduta in terra, col busto
ritto, appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e non finta ma viva; di
volto mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale guardavalo fissamente...
Diciamolo
subito: il testo in questione non è un «mimo» di Francesco Lanza, né
quell'isolano è uno dei siciliani inquieti ma stolidi che febbrilmente animano
le pagine dello scrittore di Valguarnera con le loro
strampalate intraprese, e nemmeno quella donna è una delle pigre e scaltre
virago incise a colpi di bulino nei Mimi siciliani del 1928.
Quell'inquieto viaggiatore è,
invece, un Islandese, e quella smisurata epifania è, nientemeno, la Natura. E
il testo - è appena il caso di dirlo - è un’operetta morale di Leopardi: il
Leopardi della “Ronda”, e cioè il prosatore delle Operette, prosciugate dei
loro veleni intellettuali e distillate dai rondisti come preziose e asettiche
vene di bella scrittura, di raffinatissima prosa, insomma di “stile”. E quanto
ridimensionato, anzi devitalizzato, e dunque frainteso, fosse il rivalutato
Leopardi della “Ronda”, Francesco Lanza lo intese immediatamente: proprio lui
che tanto a lungo è stato appiattito dalla critica nell’onesto decoro e nella
disimpegnata produzione di quella pletora di rondisti, “capitolisti”
e compilatori di rassettate paginette che negli anni Venti affollavano e aduggiavano
le patrie lettere.
E
infatti, già nel '21, così scriveva all'amico Navarria:
Leggo di questi
giorni il testamento letterario di Leopardi, edito dalla Ronda. Ove ci sono (in
costoro della Ronda) buone intenzioni, ma disgraziatamente completa
incapacità di attuazione. È strano che degli esseri superficiali e frammentari
si siano con tanta passione riaccostati al grande costruttore moderno. (...) Ma
sono sicuro che non costruiranno mai niente; cattivi discepoli di cotanto
maestro.
E con
lungimirante condiscendenza aggiungeva: «In ogni modo bisogna restar loro
grati - ché sono buoni disseccatori di cellule».
Tutto qua
il rondismo di Lanza: una lezione di affilata notomizzazione
del reale, ma non per disinfettarlo e sublimarlo in rarefatte movenze dello
stile, bensì per esibire impietosamente le cruente ulcerazioni e le
proliferanti metastasi di quelle «cellule» smembrate.
Ma
torniamo, per ora, a Leopardi. Alla sua Natura sorda e sinistra, a quell’Islandese
che tanto s'è agitato per fuggirla da finirle stoltamente tra le fauci. Come
gli altri isolani, i piccoli siciliani, di Francesco Lanza: il quale sa bene,
come il Leopardi di quell'operetta, che «la vita di quest'universo è un
perpetuo circuito di produzione e distruzione», insomma (in termini più
moderni) un cosmo ferocemente darwiniano governato da una fatale entropia; ma
non lo sanno i contadini dei suoi Mimi siciliani, che come l'Islandese si ostinano
a chiedere «a chi giova» codesta ciclica «dissoluzione» e come lui finiscono
con l'esserne ingloriosamente divorati.
Leopardismo, darwinismo. Potremmo aggiungere: espressionismo.
E avremmo elencato, allora, non solo tre aspre matrici dell'universo contadino
anti-bucolico, anzi in via di avanzata decomposizione, di Francesco Lanza, ma
pure tre storiche insegne della grande tradizione letteraria siciliana da Verga
e De Roberto a oggi. E in quella tradizione di astratti furori e di
progressiva liquidazione dell'idillio Lanza troverebbe, almeno per quanto
riguarda i Mimi, una collocazione più esatta, e del resto più ovvia, di
quanto non risultino le ammucchiate antologiche alla Enrico Falqui, che nel
'38 stipava nei suoi Capitoli, insieme con Lanza, vociani e rondisti, solariani ed
espressionisti, insomma leggeva sub specie capituli la letteratura italiana da D'Annunzio a Gadda.
L'Islandese aveva
ingenuamente osato chiedere «a chi piace o a chi giova cotesta
vita infelicissima dell'universo, conservata con
danno e con morte di tutte le cose che lo compongono»; non diversamente, il
contadino siciliano di Lanza impronta il suo rapporto con la natura a un
altrettanto ingenuo, e stoltamente strumentale, cui prodest.
Della latitanza, o se
vogliamo della scarna e umbratile presenza, della natura o meglio del paesaggio
nei Mimi
ha già scritto, nella prefazione del 1971, Italo Calvino. Alle sue annotazioni
converrebbe aggiungere solo che quelle rare epifanie vegetali o animali che
attraversano come per caso e di sbieco i Mimi, insomma quell'evocazione volutamente
castigata e come per sineddoche della natura, e cioè affidata ad avari ed
enigmatici frammenti, impongono il riferimento non solo, com'è evidente, alla
natura analogamente degradata, irreversibilmente alienata, del Verga delle Rusticane
o di De Roberto e Pirandello, ma anche e soprattutto alla prepotente
suggestione esercitata da un libro come Bestie di Federigo Tozzi: e cioè alla
tecnica decisamente affine, sperimentata in quelle prose con esiti di furente
espressionismo che anticipano e legittimano i Mimi di Lanza, della materializzazione
apparentemente casuale, e invero accesamente simbolica, di quelle «bestie», in
filigrana e più sovente in coda a ciascuno di quei memorabili esercizi di
purezza e di ferocia dello scrittore senese.
Ma non basta. Guardiamola un
po' più da vicino, la “natura” dei Mimi. La luna, per esempio: la «graziosa
luna» del Leopardi, la luna «vergine» e indifferente del pastore. Qui è la luna
«valorosa» del barrafranchese, «che luceva come giorno chiaro, e si specchiava
tutta in fondo all'acqua, che pareva un timballo d'argento». Già il ricorso a
metafore alimentari dovrebbe metterci sull'avviso, introducendoci alla
cosmologia degradata e commestibile di codesti contadini: e infatti il
barrafranchese, picchiando l'asino che nel pozzo ha bevuto con l'acqua la
luna, seriamente gl'ingiunge: «Vomita la luna che mi bisogna, o t'ammazzo». E
l'ammazza davvero, con una sorda ferocia ch'è peculiarmente contadina ma anche
riconducibile allo sconvolto bestiario di Tozzi (e si vedano le tante
efferatezze e le gratuite violenze reiterate nei Mimi, oppure le cruente
cicatrici che sinistramente illuminano certi apologhi come L'augello crudo). Ma,
quel che più conta, all'origine di questa sorda ferocia, all'origine di questo
rapporto con la natura degradato e vorace, gastronomico o meglio cannibalesco,
c'è il cui
prodest dell'Islandese («Vomita la luna che mi
bisogna»), c'è l'approccio
strumentale, brutalmente rapace, sordidamente possessivo che barrafranchesi o mazzarinesi o raddusani o piazzesi,
o quant'altri da tali intercambiabili toponimi siano marchiati, instaurano con
un universo sconsacrato e reificato.
Ma questa strumentalità è come impazzita, dissociata, perfino
semanticamente distorta: e così può accadere non solo che i singoli frammenti
di questo cosmo-oggetto possano scambiarsi il nome e «una pernice» possa essere
«anche un'upupa», ma che addirittura si scambino il nome i vivi e i morti come
in quello splendido apologo, I ferri ai piedi, che è un trionfo della tautologia e dell'assurdo
(e che ricorda la vertiginosa invenzione che negli stessi anni Savarese consegnava alla sua novelletta L'allarme
dei vivi):
Due caropipani,
di professione ladri, pensarono di morire; e buttatisi sul letto non davan più segno di vita. Gettaron
loro le strida, li vestirono, li misero nel cataletto e li portarono per morti
in chiesa. Ma la notte, quelli buttarono all'aria i coperchi, e più vivi di
prima si diedero a saccheggiare ogni cosa; e rotte le sbarre scapparono via per
le lunette. La mattina, aperta la chiesa, non si trovarono più i morti né le
cose di prezzo, e lo scandalo fu grande.
- Qua bisogna
provvedere - gridarono i gabbati - ché i morti non son morti e fan cose da
vivi; - e radunato in fretta il consiglio, dopo molto sputare fu finalmente
gettato a suon di tamburi e di trombe questo bando:
- Caropipani,
da oggi in poi, chi vuol morire ha da pensarci due volte; e chi non è sicuro
d'esser morto non muoia, ché quelli che son tali verran
ferrati ai piedi come muli!
E d'allora in poi, così fecero; e di caropipani non morì più alcuno che non fosse veramente
morto.
Oppure può accadere che i lercaresi si scambino perfino le gambe in un'ammucchiata
orgiastica e bruegeliana, ma anche che il licodiano rubi a se stesso in un mimo che è l’assolutizzazione
metafisica d'una rapacità fine a sè, affrancata
dalle misure e dagli obiettivi contingenti, o ancora che il mazzarinese metta «in serbo il fiato», accumuli in atri
termini non solo un bene tutt'altro che tangibile, ma addirittura il vuoto,
il nulla.
Ecco: questi eredi di don
Gesualdo Motta e della verghiana religio della
roba sono in realtà dei Robinson impazziti, dei capitalisti del nulla, e nei
loro gesti compunti mimano stolidamente l'accumulazione originaria: e così può
capitare che tre Malavoglia degradati si buttino successivamente in mare,
perdendo il prezioso carico del loro piccolo commercio marittimo, ma anche la
vita, per recuperare una sola cipolla; oppure che la prizzitana
usi il grembiule nuovo per ricavarne sgargianti toppe per quello vecchio e sdrucito.
È sempre un rapporto semanticamente distorto,
non “naturale” ma simbolico, astratto, con le cose: è sempre come se costoro
scimmiottassero la “civiltà”, come se con le loro bestiali e gratuite oltranze,
consumate in un'aura di stuporosa ebetudine,
ripetessero, demotivandoli e desemantizzandoli, riducendoli
a gags esilaranti, i gesti assorti e accorti e i
segni imperiosi del dominio capitalistico e della razionalizzazione
tecnologica della natura.
Mentre
l'esito di quella razionalizzazione era, com'è largamente noto dopo Max Weber,
il moderno «disincantamento del mondo», il risultato
dell'irrazionale - ma comicamente speculare - aggressione contadina della
natura è un'analoga sconsacrazione, ma come a ritroso, che non genera cioè l'universo
post-cristiano, secolarizzato e agnostico della “modernità” neo-capitalistica
ma al contrario regredisce verso remoti archetipi precristiani, pagani o
addirittura animistici.
Ad animare la vistosa
componente ferocemente blasfema che serpeggia nei Mimi non è, dunque, la “carnevalizzazione” del Sacro descritta da Bachtin, la quale presupporrebbe un preciso e strutturato
universo cristiano cui contrapporsi: i contadini di Lanza, invece, maneggiano
crocifissi, o addirittura li incarnano nelle ricorrenze liturgiche, e comunque
si rapportano coi rituali e le gerarchie della formalizzazione cattolica del
Sacro, come se ne ignorassero del tutto il senso e lo scopo, insomma con lo
stupore o la diffidenza o l'indifferenza con cui i cosiddetti selvaggi
potevano accogliere le bizzarre insegne religiose dei conquistatori. Di più,
di tali insegne essi fanno un uso ancora una volta distorto, dissociato, ancora
una volta ricondotto alla totalizzante matrice fisiologica del loro universo.
A far le
spese di questa desemantizzazione e risemantizzazione del Sacro sono, per esempio, il Cristo
del castrjannese e lo stesso mistero dell'Eucarestia, giacché a quel poveraccio, cui era
stato detto: «Andate in chiesa a inghiottirvi il Cristo», non par vero di
dovere «ingollare» per intero quel «Cristo risorto, alto come un saracino», e
per giunta con tutta la bandiera; oppure il «diocotto»
del mimo successivo, quel «crocifisso tutto affumicato e scacato
dalle mosche», anch'esso da ingoiare traumaticamente («Non lo sapete che Cristo
ha la testa dura?»), a causa della distorta ricezione d'una prescrizione
sanitaria. All'origine di questa Babele contadina che confonde i linguaggi e
«rinomina le cose» è una distorsione analoga, e analogamente demistificatrice,
a quella su cui è modellato il «linguaggio di Giufà»
(nei termini in cui ne ha scritto, anche recentemente, Natale Tedesco): e Giufà fa capolino, del resto, nei Mimi siciliani, per non
dire poi dei Mimi arabi dello stesso Lanza i quali, facendo da ponte tra le
due culture, restituiscono a quel modello siculo-arabo
un convincente spessore di comuni radici antropologiche.
Ma c'è di più: nelle
invenzioni terribilmente blasfeme di cui s'è detto, e mediante quel processo a
ritroso di scristianizzazione di cui pure si è trattato, il pasto mistico della
liturgia cattolica è ricondotto alle sue crude origini cannibaliche,
al pasto totemico e, dunque, alla rievocazione rituale dell'origine criminosa,
antropofagica, parricida della civiltà e delle sue
istituzioni: il castrjannese e il piazzese che
pretendono d'ingoiare il crocifisso ne sono gl'inconsapevoli e grossolani
tramiti. Ma nient'altro che un totem è, del resto, il Cristo del nicosiano,
quel feticcio ligneo già ricavato da un pero e tuttora, a detta del suo rozzo
artefice, segnato dalla sterilità di quell'arbusto avaro; e un totem
dichiaratamente fallico è il singolare ex-voto argenteo dell'assarese, oscenamente allusivo a culti altrettanto remoti;
per non dire delle sconce erezioni dei poveri Cristi da via crucis strapaesana di
Santa Caterina e di Mezzoiuso, o degl'incidenti
fisiologici occorsi ai loro colleghi di Mineo e di Petralia, che fanno pensare alla trascrizione ben
altrimenti drammatica che di questa blasfema aneddotica plebea Pier Paolo
Pasolini avrebbe proposto nella splendida Passione laica del cortometraggio La ricotta.
Animismo e totemismo,
distorsione semantica e riformulazione delle “parentele” fra le cose, tabù e
licenze, pasti tribali e perfino quello scambio simbolico delle donne frequente
fra i contadini dei Mimi, riconducono
al coerente immaginario e ai sistemi di classificazione del “pensiero selvaggio”,
insomma di quei “popoli senza storia”, di quelle società “fredde” di cui ha
trattato Lévi-Strauss. Estremo esorcismo della
Sicilia verghiana e derobertiana
contro le insidie della storia? Regressione abissale, irreversibile nel
protettivo guscio d'ostrica di categorie mentali addirittura “selvagge”,
preistoriche e perciò più che mai antistoriche? È forse eccessivo il carico
che per tal via s'imporrebbe alle fragili spalle di codesti lillipuziani di
Sicilia; e tuttavia è quasi superfluo ricordare che la via maestra del
primitivismo, del recupero di codici ancestrali o “selvaggi” in funzione della
risemantizzazione del reale, è quella trionfalmente
battuta in quello scorcio di secolo, tra fauves e
dada, tra
espressionismo e cubismo, dalle grandi avanguardie artistiche. E che nella
letteratura italiana di quegli anni era stato ancora una volta Tozzi a
introdurre siffatte vertigini, a proporre con programmatica inattualità
regressioni altrettanto spaesanti.
Quegli animali ferocemente
ammazzati, o ciecamente inseguiti fino alla morte dello sprovveduto
cacciatore, e che si scambiano il nome e gli attributi perché proprio sul nome
più che sulla sostanza, e sulle attribuzioni simboliche ad esso connesse, si
esercita quella caparbia volontà d'appropriazione e d'assimilazione, sono del
resto animali-totem, oggetto di sì sproporzionati investimenti proprio per la
loro ambivalente natura di tabù e di pasto rituale, ma soprattutto per associarne
la specie a questo o quel clan e dunque per introdurre un ordine nel
perturbante caos avvertito da codesti primitivi.
E non sarà un caso, allora,
che i personaggi di Lanza rechino denominazioni solo etniche e appunto di clan
(il piazzese, il licatese, il barrafranchese, il troinese,
il caropipano e via catalogando), come per definirli
in base al loro approccio tribale alla realtà e alla natura; o che i loro
comportamenti automatici, meccanicamente reiterati, vengano di volta in volta
motivati solo dal ricorrente intercalare «da quel piazzese che era» (o altro toponimo,
ovviamente). E del resto proprio il piazzese, a chi l'interroga sulla sua
identità tentando di riferirla a categorie un tantino più complesse («O voi -
gli fece - siete cristiano?»), risponde con scoperta ma assai significativa
ingenuità: «Gnornò: piazzese».
Ma la presenza animale,
scompostamente insidiata da uomini che ne riproducono mimeticamente la
“naturale” brutalità e comunque tendono ad assimilarla e assimilarvisi,
è nei Mimi pure il veicolo d'un
processo di «animalizzazione» del mondo umano affine
a quello descritto da Debenedetti proprio a proposito di Bestie: che è poi, a
tutt'oggi, la più chiara formulazione, non a caso suffragata dal ricorso alle
idee compositive e alle tecniche pittoriche di Franz Marc, dell'espressionismo
di Tozzi. E quella felice definizione d'un côté di scelte espressive e di moventi
esistenziali è utilmente dilatabile al mondo e alle oltranze dei Mimi siciliani, al caustico impasto di
coltissima prosa d'arte e di brusche impennate d'oscena ferocia che accende queste
acqueforti siciliane, allo scarto e alla lacerazione ottenuti da Lanza mediante
l'intrusione del comportamento bestiale o dell'inflessione dialettale, della
deformità o della turpitudine, del “motto di spirito” grevemente pornografico
o della bestemmia iperbolica dentro le maglie serrate e il giro avvolgente,
squisitamente letterario del periodare rondesco.
È lo stesso furore
espressionistico - nei Mimi addirittura più rabbioso, impudente, impartecipe - con cui Tozzi aveva violentato la compatta
superficie della realtà esterna e della prosa tradizionale per liberarne mute
epifanie e mostri enigmatici. E basterebbe istituire una parentela siffatta per
liberare definitivamente Lanza dalla ipoteca rondista e per affiliarlo a
un'area molto più mossa e variegata, soprattutto più “aperta”, che dal
frammento vociano sconfina nell'estremismo strapaesano e nel realismo
espressionistico degli anni '20 e '30: insomma, per affratellarlo a tanti di
quei nomi che Falqui forzatamente assoldava
nell'improbabile armata dei “capitolisti”.
E
proprio a Falqui, polemizzando con quell'accomodante
florilegio, Eurialo De Michelis aveva correttamente
opposto la netta distinzione fra le due poetiche, quella innovativa e polemica
del frammento e quella restauratrice e ritotalizzante
del capitolo, individuando nella prima la rottura della forma chiusa e nella
seconda la sua ricomposizione «come nuova forma compiuta e perfetta in sé».
Lanza, è appena il caso di dirlo, milita nella prima delle due opposte trincee,
la più disertata e polverosa, rigurgitante di crudezze strapaesane e deflagrante
di schegge espressionistiche. Ma dicevamo della «animalizzazione»:
torniamo allora, prima di congedarci dal bestiario dei Mimi, a quella chiave
di lettura, suggerita dallo stesso autore e anzi impressa alle sue creature
come un marchio impietoso.
A recarne il segno sono in primo luogo la designazione
e la demarcazione dei sessi, affidate a caratterizzazioni zoomorfe come quel
«petto di faraona» (o di colomba) proteso dalle donne, o come
quell'ambivalente e alterna qualifica di «toro» o di «becco» appioppata a
un'infoiata o ignava fenomenologia della virilità.
O come il sesso-«riccio» irto d'aculei della «siciliana»: e un toponimo così
insolitamente generico come quest'ultimo potrebbe pure insospettire sulla
portata di certi atavici terrori maschili (e del casto Lanza in primo luogo,
che non a caso titolava un suo testo teatrale Cosa darei per sapere com’è fatta una donna), ribaditi dalla sgomenta
definizione di «malpasso» che l’aidonese
tributa al sesso della vicina; per non dire, tornando al regno animale, di
quegli occhi della villarosana che s'incollavano
«addosso agli uomini (...) come una nassa di pesci».
Ma anche il sesso maschile è animalizzato,
sotto specie di «cucca», o vegetalizzato, come nel divulgatissimo apologo su san Pietro e il piazzese:
Un giorno
trovandosi san Pietro a passare di qua, vide il piazzese che arato il suo campo
lo andava seminando:
- O che semini? -
gli domandò.
E quello:
- Minchie, per chi
non ne ha.
- E minchie sieno - disse san Pietro, facendoci sopra la benedizione.
E alla stagione
infatti il campo produsse in abbondanza grandi minchie e rigogliose; e fu lo
spasso delle vedove, delle vergini e delle maritate, cui una sola non bastava
più.
E addirittura quel sesso può apparire volatilizzato,
come nel caso dell'impertinente e corposo «frescolino» che insidia la mistrettese. Ma è pur sempre la donna il soggetto attivo e
l'accorta regista di quest'incessante e abbrutito circuito erotico. Che tale
riconoscimento sia il frutto d'una intelligenza aperta e prefigurante o viceversa d'una paura cupamente ancestrale, non è questione che possa dirimersi
con tagli netti: anzi, tale dubbio è destinato probabilmente a cumularsi alle
numerose perplessità suscitate nel lettore e nel critico dalle altrettante
contraddizioni di Francesco Lanza.
Contraddizioni al limite della schizofrenia, e valga
una per tutte: che il feroce universo contadino dei Mimi sia inciso dalla stessa penna donde provengono i bozzetti
pedagogici dell’Almanacco per il popolo
siciliano, e cioè quella produzione idillica, ottimistica, ottocentescamente paternalistica, mediante la quale quel
mite e verecondo compilatore d'innocui lunari impercettibilmente virava dal socialismo
populistico al ruralismo fascista.
E certamente Soffici, tenendo a battesimo i Mimi siciliani mediante l'imposizione
di quel nome sottratto alla tradizione (quella inaugurata dal greco Eronda, resa sì autorevole dal tempo, ma ricca d'intatte
potenzialità trasgressive), non seppe rendersi conto della loro irrimediabile
e insolente alterità, né delle oltranze e delle infrazioni che gli scarni
apologhi di Lanza apertamente squadernavano, né della clamorosa e irridente
smentita che ne derivava alla stucchevole genìa degl'incontaminati giustizieri
villerecci alla Lemmonio Boreo
o (perché no?) all'untuoso perbenismo di vecchi e nuovi lunari.
Non è che mancassero esempi coevi, né successive
repliche, di quella contraddizione: basti per tutti il «caso» Alvaro, divaricato
fra le antitetiche frequentazioni dell'espressionistica Alexanderplatz e del
mussoliniano Agro pontino. E per di più, di tale duplicità di scelte culturali
e ideologiche e di registri espressivi, Lanza poteva rinvenire un autorevole esempio,
anzi il più autorevole e legittimante, nel Verga che dalla «fantasticheria» mondano-rurale imprevedibilmente e traumaticamente approda
al disincantato e tragicamente omologato «universo orrendo» rusticano.
E dunque l'inquietante
schizofrenia di Lanza si può anche intendere e ricomporre come la messa in
opera di tattiche differenziate al servizio d'una medesima strategia: giacché
si può combattere la storia e pretendere d'azzerarla anche battendo le vie
decisamente divergenti, ma altrettanto funzionali allo scopo, dell'idillio e
dell'anti-idillio, dell'edificazione e della polemica, dell'impressionismo
morbidamente evocativo e dell'espressionismo rigorosamente analitico.
Non
solo: altre giustificazioni potremmo
attingere pure in quelle Operette
morali dond'eravamo
partiti. E allora, all'onesto «venditore d'almanacchi» Francesco
Lanza, il «passeggere» potrebbe ancora una volta ironicamente motivare il contraddittorio
e mendace ottimismo di quella produzione ad uso del popolo con le parole della
notissima operetta leopardiana: «Quella vita ch'è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che
non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll'anno nuovo, il caso incomincerà
a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice.
Non è vero?».
Confortato
da questa strizzata d'occhio, che gli certifica l'immediata intelligenza del
suo duplice registro di smagato notomizzatore e di
svagato imbonitore, o almeno gli fornisce un alibi da stendere pudicamente su
più segrete e sofferte contraddizioni, il «venditore d'almanacchi» di Valguarnera potrà riprendere il suo richiamo sommesso e
sornione: «Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore,
almanacchi?».
CONFESSIONI
D’UN VENDITORE D’ALMANACCHI
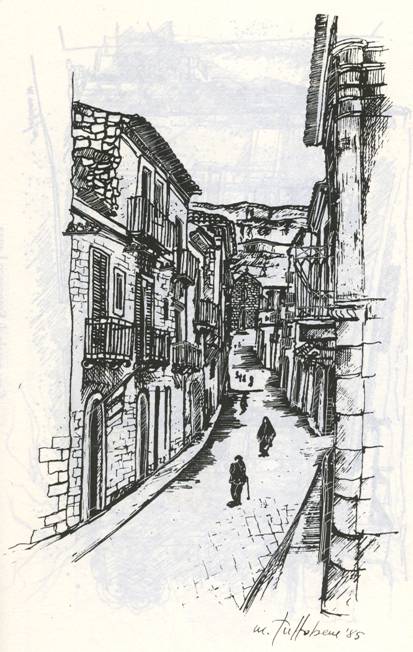
(Paese, disegno di M. Tuttobene)
Un Dialogo per il nuovo anno, fra un «venditore» e un «passante»,
Francesco Lanza l'aveva scritto, del resto: nel 1930, facendo il verso
all'amato Leopardi e fingendo di correggerne le tesi, di stemperarle in un
ottimismo d'annata. Ed è uno scritto prezioso, il suo, pur nell'apparente
mimetismo da esercitazione à la manière o
da divertita palinodia, per intendere l'inflessione sommessamente, dissimulatamente autocritica che vena la prosa del pedagogo
dell'Almanacco, e il radicale
fatalismo che la lega ai Mimi. Il
passante, infatti, vi parla il linguaggio parenetico e rassicurante del Lanza
autore di lunari per l'edificazione del popolo contadino, e parrebbe perfino
che il dialoghetto converga con gli esiti ideologici di siffatta produzione,
almeno finché il personaggio in questione non dichiara con altrettanto
imperturbabile serenità che il fine delle magnifiche sorti e progressive è «il
supremo stato di felicità nella morte».
Lo stesso
Almanacco per il popolo siciliano,
commissionato nel 1922 a Lanza da Giuseppe Lombardo Radice nell'ambito d'un
disegno d'alfabetizzazione delle masse rurali d'impronta decisamente tradizionale
e di spirito gentiliano, apriva la sua prosa nuda e
rassegnata con accenti di solidale e sofferto fatalismo:
Non t'aspettare
dal nuovo anno grandi cose. Sarà del tutto eguale agli altri anni passati: tu
bagnerai del tuo sudore la terra e ne avrai pane. Le stelle e i pianeti seguono
nel cielo sempre la medesima via. Non bisogna chiedere all'avvenire grazie
impossibili.
Dove non
è malafede da rentier, né
solo immobilistica oleografia nella plurisecolare tradizione dei “lunari”
(quella, appunto, irrisa dal Leopardi nei suoi fondamenti progressivi), ma
piuttosto è dolente sintonia verghiana con un'idea di
popolo-«ostrica» da salvare dalla bufera modernizzante che lo sradica dallo
scoglio della tradizione; piuttosto è tardiva e paradossale riappropriazione
della “protesta di Leopardi” ad opera di quella pur così diversa e acquietata
tradizione.
Leopardismo moderato, “di destra”? Potrebbe anche essere una
persuasiva definizione, a costo d'infarcirla di contenuti eterogenei quali un
certo populismo irenico da socialismo pascoliano oppure
un certo ruralismo anticapitalistico di prossima
declinazione fascista, per non dire del campionario di scettiche «parità» che
Lanza ereditava per linea diretta dalla tradizione demologica isolana. Se si
poteva far convivere, addirittura, populismo e leopardismo,
questa ed altre commistioni maturavano insomma all'insegna d'un riuso della
“funzione-Leopardi” di segno per l'appunto moderato (e tuttavia ancora “altro”
dall'esangue feticcio rondesco), fatalistico, o per
meglio dire a tal punto disperante da bruciare l'acceso nichilismo del
recanatese in un'ottenebrante e nirvanica contemplatio mortis. Che è - si dirà con
ragione - peculiarmente isolana: ma che più e prima che da moventi culturali e
gravose tradizioni di scrittura e di pensiero si genera e si brucia, nel caso
di Lanza, sul terreno extraletterario e nelle irripetibili ragioni d'una
traumatica biografia.
Una
biografia, quella di Francesco Lanza, che andrebbe riletta alla luce di remoti
archetipi: e in primo luogo, complice la morte immatura, sotto il segno di
larvale irrequietezza del puer aeternus, del “fanciullo divino”
del mito: candido e feroce, innamorato e risentito, incontaminato eppure rabbiosamente
voglioso di sporcarsi le mani con la vita. Come gli adolescenti di Tozzi (Con gli occhi chiusi) e di Vittorini (Il garofano
rosso), altrettanto inevitabilmente
irrisolti e votati ad azzeranti vertigini; come gli adolescenti i cui spiriti romanticamente
eversivi saranno da lì a poco convogliati nella scommessa caparbiamente
perdente del “fascismo di sinistra” e della partecipazione trasognata, autodistruttiva
alle guerre di regime.
Una biografia, comunque, ancora da ricostruire in
gran parte, nonostante il recente fiorire di repêchages e postumi florilegi e talora addirittura a causa
della loro incontrollata e farraginosa generosità. E tuttavia un'avara ma
icastica autobiografia è ricomposta dai carteggi: quello citato con Aurelio Navarria, l'altro con l'altro amico Corrado Sofia.
Amicizie febbrili, totalizzanti, scontrosamente possessive, in un'atmosfera da
Grand Meaulnes,
alla Alain-Fournier:
com'erano quelle, del resto, che matureranno all'ombra dell'inquietudine
intellettuale di tante riviste «giovanili» già a partire dal primo scorcio
degli anni Trenta.
Tale fervore, cullato da sogni d'ingenua palingenesi
letteraria e/o civile, doveva respirarsi tra gli artigianali artefici del periodico
“Lunario siciliano”, un foglio amabilmente rétro che pare concepito per le popolazioni isolane
dei tempi di Verga e di Pitré e tuttavia, nell'equilibristica tensione fra i divaricatissimi
modelli della “Ronda” e del “Selvaggio”, di quando in quando modula sinceri accenti
di quella moralità provinciale ch'era stata (si pensi del resto a Jahier e al suo “Il nuovo contadino”) un esito fra i più
notevoli della cultura vociana. Dal biennio ennese
(1927-'28) al riparo romano all'ombra della fascistissima
ipoteca della direzione Interlandi (aprile-novembre
'29) e all'esigua e posticcia appendice messinese del '31, la rivista di Lanza
si avvale di redattori e di assidui collaboratori quali Savarese,
Navarria, Blandini, Interlandi, De Mattei, Biondolillo,
Mezio, Bartolini, nonché delle saltuarie firme di
Cecchi e Soffici, Ungaretti e Bacchelli, Falqui e D'Amico,
Vittorini e Brancati, Cocchiara
e Bottari, Di Giovanni e Vann'Antò, e di altri protagonisti e comprimari della scena
letteraria insulare e continentale.
Un fervore, quello, che non
solo poteva esprimersi fin nel forzato esilio romano, ma pure nella
collaborazione degli stessi giovani intellettuali isolani (e oltre che a
Lanza, si pensi a Brancati) alla stampa
dell'integralismo fascista (“Tevere”, “Quadrivio”), diretta dall'ambiguo e pur
a suo modo generoso corregionale Telesio Interlandi. Ma a fronte di tali compromissioni, valgono le
definizioni che Lanza stesso ci offre di sé nei carteggi citati. E infatti si
dice «selvatico», alla Malaparte e alla Maccari, scrivendo a Sofia, mentre in
modo più pregnante si definisce «anarchico» in una lettera a Navarria: parla anzi d'un «anarchismo accontentato e
scontento» ch'è l'epitaffio più idoneo a suggellare la sua breve e scomposta
parabola, e tale da integrarsi persuasivamente con quello, qui proposto, di leopardismo moderato, populisticamente orientato a
un'estroversa esplorazione del mondo limitrofo e tuttavia esistenzialmente
radicato in un'inversa e ottenebrante regressione a più fonde pene e radici.
Di queste ulteriori
contraddizioni fanno fede le lettere all'amico (e come Navarria,
compagno d'avventure letterarie e giornalistiche) Corrado Sofia; e più atrocemente l'ultima, vergata la notte
dell'ultimo dell'anno 1932 nell'albergo
Sangiorgi di Catania, tra gli spasmi d'una febbre che
da lì a pochi giorni l'avrebbe fatto morire nella natia Valguarnera:
In questo albergo da cocottes stanno preparando le imbandigioni per il classico
cenone: per fortuna la febbre mi fa sentire tutto il disgusto di questi odori a
base di supplì. Scrivimi a Valguarnera - e speriamo
che anche questa passi.
Non passerà, appunto; e Lanza lo avvertiva
oscuramente: «ricado nella trappola, è proprio il mio destino». Era a Catania
di passaggio, giusto per spiccare il volo - e per sempre - dal «maledetto
paese» che lo «strangola lentamente», dalla «gabbia infernale» della provincia
emarginata («sequestrata», avrebbe detto Gentile).
Con Sofia, Lanza aveva da poco viaggiato nella
Russia bolscevica: fonte, quel retour
de l'URSS, di gidiane
delusioni; e che un socialista umanitario arruolato nel ruralismo
fascista potesse covare per sovrammercato anche
illusioni sovietizzanti, è cosa che non sorprende più di tanto, a riflettere
sulle incrociate e contraddittorie tensioni ideali della tormentatissima
gioventù degli anni '20-'30.
Fonte, quel viaggio, anche di aneddoti bizzarri (un
pranzo al Cremlino con lo sconosciuto Togliatti!) e di incidenze esistenziali
sulle quali converrà ulteriormente indagare: progetti di Lanza, per esempio,
quali novelle e perfino film d'ambientazione sovietica (e d'intonazione
satirica: un progetto-Ninotchka
nel cuore dell'isola e del gran carnevale dei Mimi?). Quanto alle novelle-reportages, le abbiamo scovate
sulla «Gazzetta del popolo» del '31, fresche d'un
sapore d'inedito per via d’uno pseudonimo (F. A. Bunjac)
che a tutt'oggi le occultava (e che pare registrasse la collaborazione con
Lanza dello stesso Sofia e della giovane e sfortunata dissidente russa Annie Pohl: ma quanto felicemente lanziane,
quelle pagine, e per esempio una tranche sottilmente straniante sui cani moscoviti!). E quanto alle sceneggiature,
lo scrittore accenna ad una, finita ed accantonata, d'ambiente coloniale: della
quale, come di quella “bolscevica”, non è dato sapere o immaginare alcunché,
tranne il suo significativo anticipo sui più noti modelli di quel filone,
filmati assai più in là da Alessandrini e da Genina.
Sui progetti cinematografici del privilegiato sodale
Nino Savarese ha indagato Liborio Termine; e
certamente nuovi sondaggi di tal genere su Lanza potrebbero alfine ridurre la
forbice critica che s'apre tra l'esaltazione di campanile del populistico compilatore
di lunari e la più accorta rivisitazione dell'impervio espressionismo dei Mimi.
S'è detto
a sufficienza, d'altronde, in queste pagine, di quella contraddizione che
attraversa l'opera di Lanza come una ferita; ma conviene aggiungere che la
stessa ferita apertamente sanguina, denunciando una genesi per l'appunto
biografica, in queste lettere: laddove lo scrittore scaglia cruente invettive
su quel suo «maledetto paese, dove non si parla che di debiti, di scadenze, di
miseria», eppure può scrivere: «Mai come ora io mi sono sentito attaccato a
questo paese in un modo così profondo e doloroso».
La chiave
è forse in una lettera dell'agosto '32:
Non ti lasciare
sedurre dalla campagna, uomo moderno! È come il prossimo, bisogna amarla da
lontano. La canteremo sulle bianche carte, nei libri e nei film, ma, vicina,
essa mi chiude la bocca e il cuore.
Grembo
ospitale e «trappola» mortale, dolente grumo (come non pensare a Brancati?) di comatose inerzie e d'illuminazioni brucianti
della mente e del cuore, quella provincia metafisica può essere cantata dal
«selvatico» Lanza ora mediante l'ingenua pedagogia georgica dell'Almanacco
ora
tramite il letterario e rarefatto vagheggiamento impressionistico di certe
splendide novelle (Paese al sole, L'ora del circolo) ora,
infine, come espressionistico groviglio di ottusità e ferocia, come sconvolto
bestiario strapaesano, come delirante campionario di totem e tabù di Sicilia:
come nella novella Re Porco, come nei Mimi
siciliani.
Come
potrebbe essere e com'è: queste, le isole dell'isolano e isolato Lanza. Ma la
sua Sicilia, fra le tante coniate nell'arroventata fucina della letteratura
isolana, ha un posto preciso nella multiforme geografia di quella letteratura:
che è quello, a suo modo privilegiato ma insieme aspramente desolato, del centro.
Chè tutta quella grande produzione letteraria è segretamente
governata da una tenace tensione centripeta che le fa voltare le spalle
all'esterno e al mare (all'avventura, alle tante «fughe» peraltro rientrate, ai
venti rapaci della modernizzazione) per abbarbicarsi al protettivo e paralizzante
guscio d'ostrica d'una diffidente preveggenza: e il centro disabitato e
sconsacrato cui ostinatamente guarda a forza di simboli e metafore ctonie,
notturne, materne, è proprio il cuore riarso e immedicabile dell'isola evocato
dai Lanza e dai Savarese, da un Di Giovanni
(accomunato a Lanza da simpatie felibriste), da certe
pagine di Rosso e Pirandello, e più tardi dal maestro di scetticismo Leonardo
Sciascia.
Nei
cardini di questa ferrea e costrittiva antropologia letteraria s'avvita con
qualche stridore, e tuttavia agevolmente, perfino il singolare “razzismo” del siciliano Interlandi, che sul “Lunario” di Lanza poteva proporre un'equazione
fra sicilitudine e fascismo in chiave di dolente
diffidenza e di archetipi tutt'altro che solari, eugenetici, ottimistici, quali
erano quelli della mitologia di regime. Il suo è anzi l'elogio degl'isolani
«lenti e taciturni», che «in quel tremendo silenzio meditano pesanti giudizi»,
è il tentativo di radicare il generico e generoso sovversivismo strapaesano
nelle remote e scontrose coordinate di quel “centro” e addirittura nelle profondità
ctonie del suo sulfureo “sottosuolo”: «E il fascismo ha qui nell'isola, il suo luogo geografico, ma non nei
bar o nelle piazze, ma nel sottosuolo isolano, quanto non ne piove dai
proconsoli chiacchieroni che arrivano dal continente».
E non è, questo razzismo à l'envers, un prodotto dell'orgogliosa
e rancorosa ideologia del silenzio coniata da Giovanni Verga ben prima del suo
effettivo, e tutt'altro che immotivato, silenzio di scrittore? Non è iscritto,
insomma, in un codice e in una tradizione che lo legittimano? Per intenderlo,
basta rileggere (e sempre sul “Lunario”) il giovane Brancati
di Intelligenza siciliana,
assertore d'una smagata saggezza isolana, «oppiata» e sdoppiata, in cui
precipiterebbero, condensandosi come nei Malavoglia in «una zona di calma profonda», «le virtù e i
vizi della barbarie e della civiltà dernier
cri».
Verghismo “di destra”,
orgogliosamente polemico, “primitivo” perché anti-storico (e antiletterario)
o meglio post-storico, così come, s'è detto, leopardismo
“di destra”. In termini non diversi si consuma la riappropriazione fascista di
Verga: dal Verga di regime di Bottai a quello da “movimento” di Dino Garrone e
dei giovani dell’“Universale” o del “Bargello” (e
fra costoro, Berto Ricci rivendicava anche le «lezioni di grandezza virile che
può darci Leopardi», da opporre polemicamente all'«ottimismo dei declamatori»).
Ma infine quel “centro” dell'isola e quel sordo
nucleo di disincantato silenzio, quella trincea di resistenza all'omologazione
e insomma quell'odiosamato crocevia dell'anima
siciliana, sono anche il luogo canonico d'un trauma che esplode, in quel
cruciale primo Novecento, nel ben più vasto teatro europeo: che è il dramma individuale
e collettivo, teoretico e politico, etico ed etnico, della “perdita del
centro”, del crollo dei fondamenti e delle certezze del “mondo di ieri” fra le
rovine d'una irrecuperabile unità, della diaspora e della “fuga senza fine” da
quella muta e violata dimora ma anche - e più - degli smagati nóstoi nel
suo alveo vuoto e fagocitante.
I CAMPANILI DI VALGUARNERA

(Campanile a Valguarnera, foto di S. Giarrizzo)
Prove marginali e “minori”, quelle di Lanza, se
commisurate a siffatti scenari? Forse; ma fra i “minori” vi sono dei grandi che
attingono livelli di realtà e d'espressione negati ai “maggiori”. Esclusi
dalle provvidenziali risorse della totalità epica o romanzesca e dalla
trionfale esibizione di ardue sperimentazioni o di sofferte verità, essi
raggiungono magari scali remoti e plaghe inesplorate del grande “mare
dell'oggettività”, oppure vi s'inabissano verticalmente per catturare effimeri
e umbratili trasalimenti della coscienza: luoghi periferici e perciò scartati,
nell'un caso e nell'altro, dalle grandi e collaudate rotte conoscitive battute
dai maestri consacrati.
È forse il caso, allora, di
riformulare la categoria stessa di minore, affinché essa non rimandi più a
improponibili (e storicamente deperibili) gerarchie di valori, bensì a
porzioni esigue ma altrimenti inattingibili di realtà, o a divaganti ma irripetibili
mosse dello stile. Quest'area di produzione, non irradiata dalle luminose
altezze dei sistemi di pensiero e delle grandi costruzioni poetiche o narrative, ma viceversa appartata nell'operosa
penombra di preziose e impercettibili prove d'autore, va dunque restituita, a
dispetto d'un inveterato “numero chiuso” per l'accesso alle storie, alla sua
autonoma legittimità. E allora anch'essa, non diversamente da quella
privilegiata dei «maggiori», potrà a pieno diritto rivendicare i propri grandi
autori e i propri capolavori.
Un grande
“minore”, nella rigogliosa vegetazione della letteratura siciliana del
Novecento, è per l'appunto Francesco Lanza. Finché la storiografia letteraria,
incalzata dalla nevrotica coazione a definire e contrapporre che le deriva dal
suo arrogante statuto, non si piegherà a riconoscere l'umile funzione
congetturale, tipizzante, d'ogni sorta di categoria provvisoriamente
impiegata, a non ritenere ontologiche le definizioni di scuole e movimenti e
aree di gusto e di stile (e di pensiero), accadrà che personalità sfuggenti
come quella di Lanza restino neglette, abbandonate all'insufficiente rappresentatività
del loro progetto “debole”, crocifisse alla loro contraddittorietà o
insofferenza.
Accettarle
(e addirittura incardinarvi nuove e più complesse “storie”), varrebbe viceversa
a intendere non solo la precarietà di quelle categorie, solitamente isolate e
contrapposte (nel caso di Lanza - e di tanti suoi coetanei -: rondismo e strapaese,
impressionismo ed espressionismo, tradizione e sperimentazione, in un certo
senso perfino fascismo e antifascismo), ma addirittura la loro coesistenza,
fungibilità, intercambiabilità. Come si definirebbe, altrimenti, il caso Tozzi?
A partire dall'arretratezza caparbiamente polemica delle scelte culturali e
ideologiche o dalla dirompente modernità degli esiti? Dalla duplice
auto-esclusione entro i risentiti confini della provincia e della tradizione o
dall'uso eversivo di quei luoghi canonici?
E quanto
alla generazione di Lanza, tributaria di quelle stridenti e feconde ambiguità,
è ancora sotto le ambivalenti insegne d'una condizione che potremmo definire di
“avanguardia regressiva” che si dispongono quei percorsi erratici, quei ritorni
al passato (a Verga, in primo luogo) che viceversa prefigurano il futuro,
quelle inattuali scommesse (dal calligrafismo al ruralismo,
e via rubricando) che variamente mescidate e
snaturate sprigionano inedite soluzioni e attualissime sfide. Basti pensare a
un'opera come i Mimi, che è distrattamente
passata attraverso il vaglio delle storie (ingiustamente addossandosi - fra
l'altro - l'intero carico della fragile fortuna critica di Lanza) nel mucchio
della prosa d'arte o dell'epigonismo verista, ed era
ben altro, di là da quell’equivoca apparenza.
A quegli scarni Mimi s'è dedicata, appunto, con speciale
riguardo l'altrettanto scarna frequentazione critica dell'opera di Lanza: e
certo si trattava, come s'è detto, di folgoranti exempla, di lapidarie moralità rurali, di apologhi nitidamente miniati o
di più distese intercenali da ricondurre, comunque,
a una continuità volutamente inattuale con filoni novellistici o idillici ormai
largamente desueti. E tuttavia la novellistica tardo-medievale e la tradizione
eroicomica e bernesca, l'idillio teocriteo e quello
arcadico del Meli amato e studiato da Lanza (ma non sarà piuttosto l'osceno e
feroce Tempio a irrompere nei Mimi
con risentita e devastante invadenza?), sono condizioni necessarie ma non
sufficienti, a catalogare le fonti dello scrittore di Valguarnera.
Ché anzi
quella scabra e lineare sobrietà da fioretto medioevale o da giottesca bibbia
dei poveri, che certo s'impone a prima vista, è tutto fuorché una sorta di
miracolosa naïveté oppure, anche a intenderne la squisita
letterarietà, una scelta nostalgicamente “inattuale”. E al contrario postula
matrici non soltanto colte ma pure coeve e attualissime: si pensi a quel
terreno di coltura in cui potevano concrescere e variamente innestarsi (e tanto
più nell'onnivoro orizzonte d'attesa d'una remota provincia) suggestioni del
frammentismo vociano, del capitolo rondesco e delle umorose (e rumorose) oltranze strapaesane.
E non è
nemmeno il caso d'invocare, a tutela di siffatte commistioni, l'esempio
autorevole del conterraneo Vittorini, spregiudicato allievo degli aristocratici
rondisti ma anche del plebeo ed eversivo Malaparte, nonché spericolato
animatore di cordate rivali come quelle dei solariani
e dei fascisti “di sinistra” del “Bargello”; oppure, più avanti nel tempo,
l'esemplare coesistenza di iniziatica letterarietà e di corrosive tensioni
civili, insomma di scrittura e verità, sulla linea Brancati-Sciascia.
Infatti Francesco Lanza si giustifica da sé, potendo esibire credenziali di
collaudato scrittore popolare (e si pensi all'Almanacco e al “Lunario”), assieme a impeccabili attestati di
frequentazione della “Ronda”.
Proprio
su questa marginale milizia rondesca la critica s'è
vieppiù accanita per esaltarla o negarla; e l'appiattimento di Lanza su
quell'esperienza è certamente a monte della sua singolare sventura critica:
«questa confusione», per dirla con Sciascia, lo salvava infatti «dall'accusa di
regionalismo», ma non «da quell'indistinto limbo in cui oggi giacciono i rondisti,
i postrondisti, i frammentisti,
i capitolisti». E d'altronde Lanza utilizzò
certamente quella lezione di stile, come certe prose più dei Mimi certificano, ma come laica iniziazione
ad astuzie tecniche altrove motivate ed orientate.
Altrove,
dunque: ma dove? In quel composito arsenale di spinte innovative e istanze
regressive che fu il “ritorno a Verga” degli anni '20 e '30, con
quell'esplosione di antitetici revisionismi che dell'orgogliosa
testimonianza dello scrittore catanese si servirono per modellarvi stucchevoli arcadie populiste o sovversivi “astratti furori”
giovanili, strenui epigonismi tardo-veristi o
inaudite oltranze espressionistiche. È in questo lussureggiante terreno, dove
germogliano gl'innesti più inattendibili, che l'universo orrendo e irredimibile
delle Rusticane può definitivamente rinunziare a porti franchi e a residui
idillici e, così,
può consegnarsi
alla sordida e bestiale antropologia e alle violenze espressive e conoscitive
di Federigo Tozzi. È ancora su questo terreno che il genere arcadico-consolatorio
del bozzetto agreste e la tecnica impressionistica del frammento vengono radicalmente
manipolati dal Tozzi di Bestie, che li trasforma in affilatissime
schegge d'un cosmo darwiniano frantumato, in crude epifanie dirompenti di là
dalla provvisoria e fragile scorza dell'apparenza oggettiva.
E in
verità, se il Lanza dei Mimi rimanda
inevitabilmente a Tozzi per la stolida brutalità di quel mondo rurale patologico
e teratologico e per l'arcaica esemplarità alla rovescia dei suoi apologhi
primitivamente impastati di purezza e ferocia, il Lanza delle prose più
articolate e apparentemente rasserenate impone a maggior ragione il riferimento
a Bestie in forza di più cogenti e ineludibili ragioni di
tecnica. Alludiamo per l'appunto a quel processo di «epifanizzazione»
della natura che Debenedetti ha definito nelle sue memorabili pagine
proustiane e joyciane, e cioè a quella segreta e dinamica «intenzionalità»
degli oggetti che li forzerebbe ad «esplodere verso» l'esterno e l'osservatore
e a schiudere la loro intima e recondita sostanza oltre lo sfaldato involucro
della loro materiale consistenza.
Di questa
vertiginosa tecnica d'interna disgregazione della solida compagine della
scrittura (e del mondo) del naturalismo, Debenedetti rinveniva nel Tozzi di Bestie convincenti e cruciali esempi, accostati - come s'è detto
- alle Idee costruttive, alle tecniche
destrutturanti e alla decomposta zoologia del pittore espressionista Franz
Marc. Ma a prescindere dall'evidente suggestione di siffatte analogie, che
paiono consacrare il mondo sconvolto e le forme ellittiche dei Mimi al riparo di più autorevoli e
acclarate sperimentazioni, è alle prose che bisogna piuttosto rivolgersi per
rintracciare procedimenti altrettanto eversivi.
Si legga l'incipit di Paese al sole:
L'ora del sole a
picco coglie alla sprovvista il paese, lo fulmina a bruciapelo, lo fa restare a
strapiombo come sospeso a un filo dall'alto deserto del cielo incandescente. Le
strade si spalancano all'infinito, squadrate simmetricamente dalla luce
abbagliante che a dirotto vi imperversa, le case si rarefanno addossandosi
l'una all'altra come per ripararsi, ma invano, a vicenda. I coni dei campanili
si sfaldano in confuse vibrazioni, livellandosi ai tetti distesi in una sola linea all'orizzonte; il panorama s'appiattisce
sotto l'uniforme superficie della canicola.
L'abbacinata
topografia della campagna ennese come i campanili proustiani di Martinville: una deflagrante tensione centrifuga s'insinua
ad un tempo nell'opaca compattezza del paesaggio verista e nell'elegante ordito
della pagina di sapore rondesco, slabbrandone i
contorni e scucendone le trame con furente modernità. Dice bene Zago, quando legge nel leggendario «sorriso di Lanza», che
aveva colpito Vittorini e su cui ha insistito in sede critica Petrucciani,
«un'acuminata e disincantata percezione dello spaccarsi e scoscendersi delle
cose, che è il destino doloroso dei “tempi moderni”». E Tedesco, quando
scrive, trattando di queste prose ma segnalando già nei Mimi le premesse di questa rivoluzione nella topica isolana: «La
linea demotica siciliana (...) abbandona la rappresentazione sociologica
obiettiva e privilegia lo scandaglio verticale, il taglio soggettivo».
Ebbene: questo processo si
consuma, fino a bruciarsi in esiti di assoluta rarefazione, nella transizione
alle prose, e cioè nell'itinerario lungo il quale (per citare ancora Tedesco),
«abbandonato il mondo contadino, Lanza trascorre dalla crudezza infernale di
quello al tedio purgatoriale del mondo borghese di
paese». Si legga anche Febbre, quel
virtuosistico esercizio di stile che della sensibilità distorta da un'innocua
alterazione patologica fa veicolo d'inedite percezioni:
Allora, con una lenta decomposizione,
le casse accatastate intorno, le vesti pendenti dagli attaccapanni, le melecotogne, i materassi e la coltre con le curiose
efflorescenze e i geroglifici bianchi di cotone tessuto, s'arrotolavano e montavano
verso di me, cercando di coprirmi, con la metodica e immane ascensione delle
nubi agglobate ai piedi di Gesù nel cielo. Alla
interna incandescenza della mia febbre, tutte le cose perdevano il loro
contorno massiccio, si sfacevano negli elementi originari, in una incorporea e
fatua deliquescenza, fuori dalla comune irrealtà delle forme. Anche le pareti,
la luce, le impressioni del giorno e della notte, i ricordi stanchi e
abbattuti come uccelli su una neve di bambagia, diventavano quell'amalgama
evanescente e nebuloso che minacciava continuamente di sommergermi e sul quale
galleggiavo sospeso appena a un filo, con un senso di soffocazione e di
soprassalto, e con un viscido crampo allo stomaco. Ancora un poco e sarei
sprofondato in un gorgo nero e impenetrabile, mi sarei librato al di là di
quelle nubi che montavano continuamente, senza pertanto progredire mai. Dal soffitto
che s'apriva accartocciandosi e arrotolandosi come tutto ciò che mi circondava,
la luna enorme e rossastra, posata sopra un albero come un cembalo, mi leccava
con ironica dolcezza la faccia che s'imperlava alla misteriosa umidità della
notte.
La
«lenta decomposizione» degli oggetti più familiari
in perturbanti impasti cromatici e morfologici provoca a sua volta stranianti
intermittenze del cuore:
Anche ora, quando
nel buio arido della notte la febbre m'investe come il fiato d'una fornace spossando
le segrete sorgenti dei sensi, quella stessa decomposizione mi riporta con una
impercettibile caduta al fondo della mia infanzia. Fuso come in un crogiuolo,
nella massa cinerea e impalpabile delle cose che si sfaldano e s'arrotolano ai
miei piedi montando su di me senza coprirmi, il mondo è quello vago e fluido
d'allora, nello stanzino ingombro di casse, di scialli, di melecotogne
e di quadri sacri.
Quella frantumazione divisionistica del mondo
esterno e della sua «realtà vacillante» qui si fa tramite d'uno smemorante
percorso centripeto e d'una gratificante regressione edipica, convergenti
verso un'interiorità nutriente e calorosa, capace di schiudersi in torpide e
nebulose epifanie ma anche di scivolare in quella condizione estrema e difficilmente
reversibile in cui «basta appena uno strappo» per piombare sofficemente e
irrimediabilmente nel vuoto. E la presenza tutelare del fantasma materno
(«avvolgeva lentamente il mio corpo, mi bruciava il sangue col lento incendio
del suo fiato, si fermava sulle mie pupille come un'enorme farfalla bianca»),
se ancora una volta fa pensare a Proust e a certi leggendari dormiveglia
protratti ad arte nelle estenuanti serate di Combray,
o alle volatili fantasticherie di Bruno Schulz che con proustiana morbidezza
riscriveva gli incubi di Kafka, assai più direttamente rimanda a un irrisolto
nodo esistenziale, a un'ombra che di volta in volta allungherà, sugli ultimi
anni di vita del giovane scrittore, protettivi chiaroscuri e luttuose tenebre
fermentanti di rimorso.
Altri esempi si potrebbero produrre, di tali
vertigini espressive, ma la Sicilia panica e dionisiaca
delle prose di Lanza merita d'essere percorsa anche sulla traccia d'altre
piste, e perfino di orme impresse da presenze numinose e di ombre proiettate da
remoti archetipi. È il caso della mitica atmosfera da incubo meridiano che
avvolge e sconvolge quegli assolati e desolati paesaggi, e soprattutto pervade
il singolare divertissement
arcadico dal titolo Proserpina nella masseria, dove la Sicilia bruegeliana dei Mimi
fa da sfondo al ratto d'una ritrosa kore rusticana e presta alla ciclica vicenda della natura, figurata in quel
mito, colori e suoni da fiera fiamminga e da carnevalesco “mondo alla
rovescia”.
E ancora, come creatura
intermedia fra l'ottuso villano dei Mimi e l'involontario “briccone divino”
del mito, andrebbe doverosamente citato il protagonista contadino della
novella Re
Porco: dalla magica esumazione d'una enigmatica effige zoomorfa all'accecante cedimento alle grazie tentacolari d'una
Erinni paesana, è tutto un incalzarsi di grossolane astuzie e picaresche grullerie fino a quel finale («ma io vi dico che era
Re Porco che se la tirò per i capelli») che ribadisce ironicamente quella
chiave mitica come patetico alibi per una balorda storia d'ordinaria follia.
Come in un'improbabile oasi
da mille e una notte (e Lanza scrisse pure deliziosi Mimi arabi), la
narrazione è anche un rito che esorcizza la morte popolando di parole il
deserto: e lo scrittore siciliano si dedicò, infatti, con disperata diligenza
a riempire di elaboratissime intelaiature verbali il
vuoto della giornata agreste e di quella paesana. Di quest'ultima ci consegna,
nelle sue prose, divertenti ma tutt'altro che divertiti reportages in cui pare animare uno spettrale museo d'ombre imponendogli la
fittizia vita d'una scrittura agile e freschissima. In questo senso L'ora del circolo è la più notevole di
tali tranches de vie; e la progressiva animazione delle polverose sale della memoria mediante
le rituali sfilate di habitués, rigidamente scandite dalle vistose
stimmate delle classi, del censo e delle generazioni, così come certi mirabili
ritratti di fatui «adoni feudali», che «squartano sull'altare del ricordo e del
desiderio le veneri inveterate e immaginarie dei loro peripli», anticipano e
prefigurano la metaforica Catania brancatiana,
castello d'Atlante e crocevia di mute e vane ricerche di fantomatici Graal,
incarnati nella larvale inconsistenza d'una inattendibile utopia o d'una
impraticabile fantasticheria erotica.
Per
verificare il sottile erotismo pre-brancatiano di
Lanza si vedano, infine, certi morbidi ritratti di «fanciulle che maturano
lentamente in casa come i fichi secchi e l'uva passa al sole», certe estenuate
evocazioni di «volti consumati dall'insonnia» e «pieni di una dispersa
dolcezza» e di occhi che «tra le lunghe ciglia hanno umili e promettenti
fulgori da focolare domestico»; e non si potrà fare a meno di avvertire, in
quegli interni fermentanti d'ombra e di sogni, quell'inconfondibile «odore di
velo, di pelle bruscamente riscaldata dal sangue, di forcine di tartaruga e
d'indumenti conservati a lungo insieme a vecchi fiori» che da lì a poco
emanerà Barbara Puglisi nel Bell'Antonio
di Brancati.
Oltre il velo di umano pudore
e di consumata letterarietà steso da queste prose disseminate su riviste e
quotidiani (e raccolte postume in volume assai più tardi), è semmai il teatro
di Lanza a convogliare, e piuttosto agl'inizi dell'itinerario creativo dello
scrittore, accenti di più franco erotismo: è così nella farsa Il vendicatore, che a Musco parve
addirittura troppo sboccata e che invece gioca prevalentemente su contrappunti
linguistici e ammiccamenti metaletterari; è così
nell'acceso Corpus Domini che fu
rappresentato nel '27 al Teatro degli Indipendenti da Bragaglia, e che nella
ricerca programmatica dell'eccesso mediante
la sovrapposizione al rito d'un profanissimo
amplesso, finisce tutt'al più col proporsi come un'esangue variante del Rosario di De Roberto o peggio di Malìa di Capuana (ma
si veda pure la Sagra di Pirandello
o, due anni dopo la pièce di Lanza,
la sconsacrata Messa della Misericordia di
Pietro Mignosi).
Ed è
così, infine, nella «favola ariostesca» Fiordispina, del '22: una
fantasticheria velatamente omosessuale, sottilmente morbosa, intrisa di pirandellismo («Quale pazzia può superare questa, che tu
sei donna come me, che il tuo sesso è una fedele copia del mio, mentre il mio
desiderio per te dovrebbe trovarti diverso?»). Ma è un pirandellismo decantato in arcadia, sublimato e stilizzato:
così come l'ossessione della verginità che pulsa dentro il falsetto fittiziamente pacificato dell'aulico fraseggio (e che
Lanza doveva avvertire come una spina ben altrimenti lacerante).
Ma di queste ed altre pene, e
di queste ed altre pagine, s'è detto abbastanza, troppo - anzi - per non temere
di offendere il sorridente e doloroso riserbo di Francesco Lanza. Resta fuori
la questione-romanzo: ma quel mutilo Vita e miracoli di Giustino Lambusta,
che non si saprebbe se affidare a un filologo o a un détective,
con quei due capitoli superstiti e scompagnati, sottratti al
laboratorio di Lanza, con la sua struttura impietosamente squadernata,
divaricata, è per l'appunto poco più che un residuato d'officina. Ma è anche, a
leggerlo con uno sforzo d'immaginazione, il solco d'un possibile crocevia: tra
la scrittura del primo capitolo, felicemente attestata sulla trincea d'un postverismo
vivace e curioso, polemico e analitico, dove l’indiretto libero di Verga e De
Roberto può illuminarsi dell’“umorismo” di Mattia Pascal, e quella del terzo,
che viceversa con esibito disagio e sofferta precarietà s'avvia lungo il
tracciato volutamente anonimo e sgradevole, “inetto” e scritto “male” che va
da Uno,
nessuno e centomila ai romanzi di Angelo Fiore, che è poi quello del
più pieno e disincantato Novecento.
All’incrocio di molte strade
e non tutte secondarie, l'opera di Lanza può fare a meno, tuttavia, di
siffatti esercizi d'immaginazione critica per contribuire, in forza
d'inquietanti epifanie o di suadenti intermittenze del cuore, a illuminare gli
accidentati percorsi e la sconvolta segnaletica della nostra memoria
collettiva.
(Antonio
Di Grado, "Il mondo offeso di Francesco Lanza" in Finis Siciliae. Scritture
nell'isola tra resistenza e resa, Acireale-Roma,
Bonanno Editore, 2005, pp. 71-100)